ANNA MARIA CURCI, PROSA, PROSABATO, RACCONTO, REDAZIONE, RUBRICHE
proSabato: Jorge Luis Borges, Il libro di sabbia
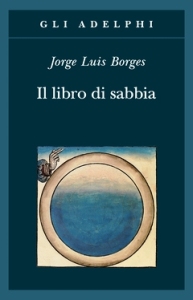
La linea è costituita da un numero infinito di punti; il piano, da un numero infinito di linee; il volume, da un numero infinito di piani; l’ipervolume, da un numero infinito di volumi… No, decisamente non è questo, more geometrico, il modo migliore di iniziare il mio racconto. È diventata ormai una convenzione affermare che ogni racconto fantastico è veridico; il mio, tuttavia, è veridico.
Vivo solo, a un quarto piano di calle Belgrano. Qualche mese fa, verso sera, sentii bussare alla porta. Aprii ed entrò uno sconosciuto. Era un uomo alto, dai lineamenti indistinti. Forse era la mia miopia a vederli così. Tutto il suo aspetto lasciava trasparire una dignitosa povertà. Era vestito di grigio e aveva in mano una valigia grigia. Intuii subito che era straniero. All’inizio mi parve vecchio, poi mi resi conto che ero stato tratto in inganno dai suoi radi capelli biondi, quasi bianchi, come quelli degli scandinavi. Nel corso della nostra conversazione, che non sarebbe durata neppure un’ora, seppi che veniva dalle Orcadi.
Gli indicai una sedia. L’uomo tardò a parlare. Emanava un senso di malinconia, come me adesso.
«Vendo Bibbie», spiegò.
Non senza pedanteria gli risposi: «In questa casa ci sono varie Bibbie inglesi, compresa la prima, quella di John Wiclif. Ho anche quella di Cipriano de Valera, quella di Lutero, che letterariamente è la peggiore, e un esemplare della Vulgata latina. Come vede, non sono esattamente le Bibbie a mancarmi».
Dopo un attimo di silenzio, ribatté: «Non vendo solo Bibbie. Posso mostrarle un libro sacro che forse le interesserà. L’ho acquistato ai confini di Bikaner».
Lo tirò fuori dalla valigia e lo posò sul tavolo. Era un volume in ottavo, rilegato in tela. Senza dubbio era passato per molte mani. Lo esaminai; il suo peso insolito mi sorprese. Sul dorso c’era scritto Holy Writ e sotto Bombay.
«Sarà dell’Ottocento», osservai.
«Non lo so. Non l’ho mai saputo», fu la risposta.
Lo aprii a caso. I caratteri mi erano sconosciuti. Le pagine, che mi parvero logore e povere dal punto di vista tipografico, erano stampate su due colonne come una Bibbia. Il testo era fitto e disposto in versetti. Negli angoli in alto comparivano cifre arabe. Attrasse la mia attenzione il fatto che la pagina pari portasse (mettiamo) il numero 40.514 e quella dispari, successiva, il 999. La voltai: il verso aveva una numerazione a otto cifre. C’era anche una piccola illustrazione, come si usa nei dizionari: un’ancora disegnata a penna, come dalla mano goffa di un bambino.
Fu allora che lo sconosciuto mi disse: «La guardi bene. Non la vedrà mai più».
C’era una minaccia nell’affermazione, non nella voce.
Guardai bene il punto esatto e chiusi il volume. Poi lo riaprii immediatamente. Cercai invano la figura dell’ancora, pagina dopo pagina. Per nascondere il mio sconcerto, gli chiesi: «Si tratta di una versione delle Scritture in qualche lingua indostanica, non è vero?».
«No», rispose.
Poi abbassò la voce come per confidarmi un segreto: «L’ho acquistato in un villaggio della pianura, in cambio di qualche rupia e della Bibbia. Il proprietario non sapeva leggere. Ho il sospetto che nel Libro dei Libri vedesse un amuleto. Apparteneva alla casta più bassa; la gente non poteva calpestare la sua ombra senza contaminarsi. Mi disse che il suo libro si chiamava Il libro di sabbia, perché né il libro né la sabbia hanno principio o fine».
Mi invitò a cercare la prima pagina.
Appoggiai la mano sinistra sul frontespizio e aprii il volume con il pollice quasi attaccato all’indice. Fu tutto inutile: tra il frontespizio e la mano c’erano sempre varie pagine. Era come se spuntassero dal libro.
«Ora cerchi la fine».
Fu un nuovo fallimento; riuscii a stento a balbettare con una voce che non era la mia: «Non può essere».
Sempre sottovoce, il venditore di Bibbie mi disse: «Non può essere, ma è. Questo libro ha un numero di pagine esattamente infinito. Nessuna è la prima, nessuna l’ultima. Non so perché siano numerate in questo modo arbitrario. Forse per far capire che i termini di una serie infinita ammettono qualunque numero».
Poi, come se pensasse a voce alta: «Se lo spazio è infinito, siamo in qualunque punto dello spazio. Se il tempo è infinito, siamo in qualunque punto del tempo».
Le sue considerazioni mi irritarono. Gli chiesi: «Lei è religioso, non è vero?».
«Sì, sono presbiteriano. La mia coscienza è pulita. Sono sicuro di non aver imbrogliato l’indigeno quando gli ho dato la Parola del Signore in cambio del suo libro diabolico».
Gli assicurai che non aveva nulla da rimproverarsi e gli chiesi se era di passaggio da queste parti. Mi rispose che pensava di rientrare in patria nel giro di qualche giorno. Seppi allora che era scozzese, delle isole Orcadi. Gli dissi che personalmente amavo la Scozia per via di Stevenson e Hume.
«E di Robbie Burns», mi corresse.
Mentre parlavamo, continuavo a esplorare il libro infinito. Con finta indifferenza, gli chiesi: «Ha intenzione di offrire questo curioso esemplare al Museo Britannico?».
«No. Lo offro a lei», ribatté e fissò una cifra elevata.
Gli risposi, in tutta sincerità, che quella somma era inaccessibile per me e mi misi a riflettere. In pochi minuti il mio piano era ordito.
«Le propongo uno scambio – gli dissi. – Lei ha ottenuto questo volume per qualche rupia e per le Sacre Scritture; io le offro l’ammontare della mia pensione, che ho appena riscosso, e la Bibbia di Wiclif in caratteri gotici. L’ho ereditata dai miei genitori».
«A black-letter Wiclif!», mormorò.
Andai in camera mia e gli portai il denaro e il libro. Sfogliò le pagine e studiò la copertina con fervore da bibliofilo.
«Affare fatto», disse.
Parlammo dell’India, delle Orcadi e degli jarls norvegesi che le avevano governate. Era notte quando l’uomo se ne andò. Non l’ho più visto, né ho mai saputo il suo nome.
Pensai di mettere Il libro di sabbia nello spazio vuoto lasciato dal Wiclif, ma alla fine decisi di nasconderlo dietro alcuni volumi scompaginati delle Mille e una notte.
Andai a letto e non dormii. Alle tre o alle quattro del mattino accesi la luce. Presi il libro impossibile e iniziai a sfogliarlo. Su una pagina vidi l’incisione di una maschera. Nell’angolo in alto c’era un numero, non ricordo quale, elevato alla nona potenza.
Non mostrai il mio tesoro a nessuno. Alla gioia di possederlo si aggiunse il timore che me lo rubassero, e poi il sospetto che non fosse davvero infinito. Queste due preoccupazioni aggravarono la mia vecchia misantropia. Mi restavano alcuni amici; smisi di vederli. Prigioniero del libro, quasi non mettevo piede fuori di casa. Esaminai con una lente il dorso logoro e le copertine ed esclusi la possibilità di un qualche artificio. Mi resi conto che le piccole illustrazioni si trovavano a duemila pagine una dall’altra. Le annotai pian piano in una rubrica, che non tardai a riempire. Non si ripetevano mai. Di notte, nelle rare tregue che mi concedeva l’insonnia, sognavo il libro.
L’estate declinava quando compresi che il libro era mostruoso. A nulla valse considerare che era non meno mostruoso di me, che lo percepivo con gli occhi e lo palpavo con dieci dita dotate di unghie. Sentii che era un oggetto da incubo, una cosa oscena che infamava e corrompeva la realtà.
Pensai al fuoco, ma ebbi paura che la combustione di un libro infinito fosse altrettanto infinita e soffocasse il pianeta nel fumo.
Ricordai d’aver letto che il luogo migliore per nascondere una foglia è un bosco. Prima di andare in pensione lavoravo alla Biblioteca Nazionale, che ospita novecentomila volumi; so che a destra dell’atrio una scala curva scende nel seminterrato, dove sono i periodici e le mappe. Approfittai di una distrazione degli impiegati per abbandonare Il libro di sabbia su uno degli scaffali umidi. Cercai di non far caso a quale altezza né a quale distanza dalla porta.
Mi sento un po’ sollevato, ma non voglio neppure passare per calle México.
Edizione di riferimento: Jorge Luis Borges, Il libro di sabbia, A cura di Tommaso Scarano. Traduzione di Ilde Carmignani, Adelphi 2018 (precedenti edizioni Adelphi 2004 e 2014)